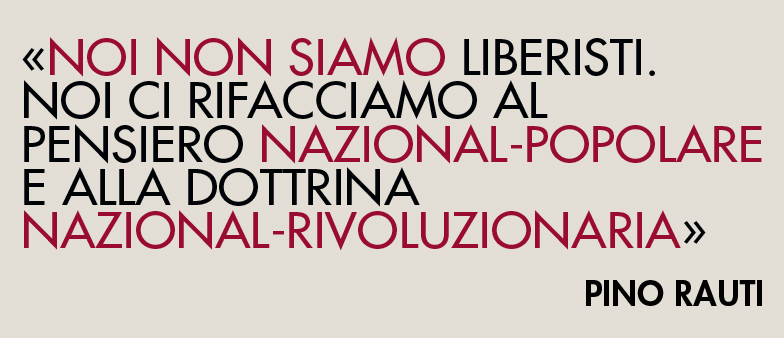Non c’è, forse, tema sociale più discusso della “flessibilità”; che in Francia sta dando luogo ad una specie di nuovo ’68 e che in Italia è entrato a più non posso nel dibattito pre-elettorale.
Per documentazione attuale, ci riferiamo a quanto ha pubblicato di recente Sergio Romano, nella sua sempre vivace e tempestiva rubrica “lettere al Corriere”, rispondendo allo scritto fattogli pervenire dal milanese Paolo Preci. Che si riferisce a quello che Romano ha detto di recente a “radio 3”, definendo la flessibilità “una buona cosa”.
Il lettore ritiene invece che la flessibilità sia troppa, sia eccesiva, “vista la difficoltà che trovano i giovani a sistemarsi con un minimo di certezza sulla durata del rapporto di lavoro”.
Secondo il lettore milanese è un errore sostenere – come fanno tutti, aggiungiamo noi; anche gran parte della sinistra – che “senza la flessibilità” le aziende non assumerebbero. Le aziende in realtà “assumono così perché è più conveniente (meno contributi), possono disfarsi del personale quando vogliono e tengono gli stipendi più bassi. Mi dica, “ prosegue Preci ” a che carriera può ambire un giovane che viene assunto a progetto per un anno e poi ancora un altro anno, così via? Non le sembra che il precedente contratto di formazione lavoro, al massimo biennale, al termine del quale si poteva licenziare, fosse una flessibilità sufficiente?”
Nella risposta Sergio Romano sostiene che occorre cominciare “con qualche precisazione e qualche dato, in quanto i vecchi contratti di formazione lavoro degli anni Ottanta e Novanta sono stati sostituiti dai «contratti d’inserimento » previsti dalla legge Biagi. Fu necessario “ prosegue Romano” cambiare perché la Commissione di Bruxelles temeva che la vecchia formula nascondesse, soprattutto al Nord, un indiretto aiuto alle imprese e fosse quindi contraria alle regole della concorrenza nel mercato unico.
Ma sembra che alcuni contratti della legge Biagi, tutti generalmente denominati con termini inglesi (job sharing, staff leasing, job on call), siano poco richiesti dagli imprenditori e rappresentino meno del 10 per cento della nuova occupazione.
Restano i co.co.co. della Pubblica amministrazione e i co.co.pro del settore privato, i soli che abbiano goduto di un certo successo. Tenga presente, tuttavia, che la crescita dell’occupazione in questi ultimi anni è dovuta soprattutto alla regolarizzazione di molti immigrati (circa 700.000), resa possibile dalla legge Bossi-Fini, e che la maggior parte dei nuovi posti di lavoro creati in questo periodo continua a essere a tempo pieno e indeterminato.”
Inoltre, continua Sergio Romano, riferendosi alle ricerche dell’”Associazione Nuovi Lavori”, “ i contratti a tempo indeterminato rappresentano il 73,2 per cento del totale mentre gli altri si dividono in due categorie: quelli a tempo determinato stipulati con leggi adottate prima della riforma Biagi sono il 17,6 per cento e quelli stipulati con contratti successivi alla legge sono il 9,2 per cento.
Insomma il fenomeno del precariato del precariato non è recente perché Come ha osservato Fiorella Kostoris Padoa Schioppa nel Sole 24 Ore del 14 marzo, “la flessibilità nel mercato del lavoro italiano è molto aumentata nel 2003 (l’anno della legge Biagi, ndr) rispetto alla fine degli anni Novanta dove già risultava, grazie al Pacchetto Treu del 1997, in forte aumento rispetto a dieci anni prima”.
Ma è o no “una intollerabile spada di Damocle” come viene percepito nella società, molto esteso o meno esteso che sia?
Continua Sergio Romano: “È certamente vero che i contratti a tempo determinato possono produrre in alcuni casi una evidente ingiustizia. In un articolo pubblicato dal Corriere del 14 marzo Pietro Ichino scrive che molti co.co.co, nella pubblica amministrazione, offrono «una prestazione più intensa e qualificata di tanti dipendenti di ruolo inamovibili» e che questi ultimi «possono permettersi di essere inefficienti, mentre proprio i fuori ruolo sono più efficienti: se non lo fossero perderebbero il lavoro »… ma è il solo modo “conclude Romano” per raggiungere lo scopo senza rinunciare alla flessibilità di cui l’industria ha bisogno per stare al passo con le grandi trasformazioni economiche di questi anni, è quello di riformare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che prevede la giusta causa per il licenziamento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tutte le leggi sul lavoro precario adottate negli ultimi vent’anni sono il risultato di un anacronistico provvedimento che ha imprigionato il mercato del lavoro in una gabbia di ferro.”.
Essendo il tema più che aperto, come notavamo all’inizio, avremo modo di tornare sull’argomento ma intanto sottolineiamo che, nella pur lunga ed articolata risposta di Romano, manca del tutto una “analisi sociale” delle conseguenze della flessibilità e di tutte le forme del lavoro precario, tra le quali conseguenze indichiamo innanzitutto il senso di incertezza e quasi “vuoto esistenziale” cui è condannato un giovane che lavori nelle suddette condizioni.
E poi: perché non si pensa alle “ricadute” ancora più gravi che riguardano la possibilità di metter su famiglia e fare, da giovani, bambini?
Chi le paga, che le sconta?
Pino Rauti