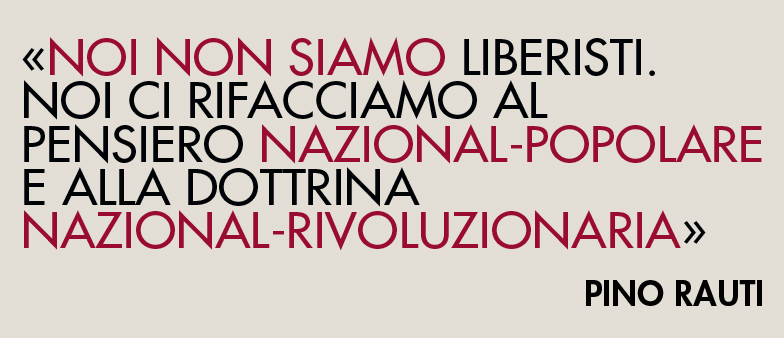[La data originale di pubblicazione del presente articolo è precedente a quella attuale – © Centro Studi Pino Rauti – Tutti i diritti riservati]
Lo abbiamo saputo da sempre, quello che era successo – di sanguinoso e di “barbaro” – al Nord, dopo il 25 Aprile, spesso ne abbiamo scritto e molti libri – primi fra tutti i volumi interi che Pisanò dedicò, documentatissimi, a quelle vicende – ne fanno testo. Ma è stato solo negli ultimi mesi e dopo il clamoroso – e coraggioso! – libro di Pansa in materia che la verità è emersa agli occhi della opinione pubblica più vasta. Al “Sangue dei vinti” si aggiungono così, si può dire ogni giorno, altre pagine.
Una pagina intera l’ha pubblicata ad esempio “Il Giornale” del 2 novembre scorso, con articoli di Carlo Cozzi e il “parere” dello storico Roberto Chiarini.
Scrive il prof. Chiarini – che è docente di Storia contemporanea all’Università Statale di Milano e presiede il “Centro Studi sulla RSI” – che questa del “Giornale” è, appunto, “un’altra pagina di normale, quotidiana brutalità, in cui sembra perso persino il normale comune sentimento di umanità, “qualcosa” insomma, che dovrebbe essere una eccezione “ma che è purtroppo storia corrente in tempo di guerra civile. Un’altra pagina da aggiungere al voluminoso libro che, dopo Pansa, tutti ormai chiamano <<Il sangue dei vinti>>.
E così prosegue: “Una pagina quindi che, da questo punto di vista, di per sé non aggiunge nulla di nuovo all’ orrore di quei giorni. Solo cinque croci in più da aggiungere alle ventimila già erette. Se il bilancio dei giovani ex-militi della Rsi fatti fuori a guerra terminata si appesantisce, non per questo è da rivedere il giudizio storico su quella tragica vicenda. Non è contando i morti e nemmeno gonfiando la macabra contabilità degli eccidi consumati per pura volontà di vendetta o per il soprassalto di una ferocia che può essere motivata solo invocando la consuetudine con la morte propria dei tempi di guerra, che si può far cambiare il significato di una partita in cui era in gioco la riconquista di una libertà conculcata. Ma, assodato questo punto, non si può dichiarare che ogni questione è chiusa. Sorgono spontanei invece almeno due. interrogativi. L’uno connesso al silenzio, quasi una volontà di rimozione, se non di occultamento di quegli anni. Un altro relativo alle tante «rivelazioni» – ma, per lo più, riguardano vicende già acclarate, anche se trascurate – di questi ultimi anni. Si può capire che una Repubblica tanto bisognosa di legittimità come la nostra priva com’era di precedenti esperienze larghe e prolungate di democrazia partecipata, al suo sorgere avesse bisogno di un mito fondativo. Questo non poteva che essere costruito sull’ epopea, ancora palpitante, della Resistenza. Quel che sorprende è che questo mito sia stato costruito rifuggendo dal riconoscere la verità; pur incontrovertibile, delle violenze perpetrate da parte dei partigiani, e in particolare delle tante consumate all’indomani del 25, aprile. La stampa ostile alla sinistra ebbe un bel prodigarsi, già nell’immediato, a documentare gli eccidi, ad esempio, del «Triangolo della Morte». I vari Giannini o Guareschi e, più tardi, i vari Pisanò hanno avuto un bel chiedere conto di quelle drammatiche uccisioni. Tutto è stato inutile. Invece di accettare l’evidenza dei fatti e ripartire da quella tragica pagina per rilanciare le proprie ragioni a sostegno della democrazia appena riconquistata, da parte antifascista si è preferito far affidamento sulle ragioni dei vincitori per misconoscere anche l’onore delle sepolture ai vinti. A distanza di tempo, bisogna riconoscere che questa sarà anche stata una scelta obbligata per certi versi nella temperie di quegli anni, ma è difficile non convenire oggi che non è stata una scelta lungimirante. Perché ha alimentato negli sconfitti la convinzione di essere doppiamente vittime. Perché non ha fatto conto che la verità paga, sempre, oltre al fatto che – non è difficile, prevedere – prima o poi viene a galla. Perché tradisce quasi il timore negli, antifascisti che la loro causa non avesse una forza intrinseca così spiccata da imporsi senza un addomesticamento della verità. Al silenzio degli anni della Guerra Fredda fa contrasto la debordante voglia di verità di questi ultimi anni. La favorisce il clima meno intossicato di passioni politiche contrapposte succeduto alla caduta del comunismo. La incoraggia la ricerca di una memoria del passato recente meno irriducibilmente lacerata. La reclama anche chi fa del riconoscimento della buona fede o della fede testimoniata con il sacrificio della propria vita il passaggio obbligato per ottenere una pacificazione e possibilmente per far passare, di contrabbando, l’equiparazione delle opposte ragioni dei combattènti di allora. La pericolosità della manovra non giustifica comunque che da questo accertamento di verità bisogna passare per ottenere, non un’impossibile memoria condivisa, ma una memoria non, cieca, anche se inconciliabile sul piano dei valori”.
Il titolo dell’articolo di Carlo Cozzi, è “Il triangolo della morte” ed è accompagnato da una grande foto, di un reparto di giovani volontari della RSI, con accanto la foto piccola di Marcello Cozzi; egli “aveva appena 18 anni. Non aveva mai combattuto. Fu assassinato dai partigiani con gli altri passeggeri della <<corriera fantasma>> nel maggio del ‘45”. Il 19 maggio del 1945, quasi un mese dopo il 25 Aprile. Ed ecco il testo dell’articolo:
“«La verità ci fa liberi», così Giorgio Zavagli, medico «geriatra, docente all’Università di Ferrara, riassume e definisce, parafrasando un versetto del Vangelo di Giovanni (VIII, 32), il senso di quella che potremmo definire una “missione laica”, che lo ha spinto da più di un trentennio – lui, liberale fermamente legato ai valori della democrazia – a operare per la conservazione della memoria di cinque ragazzi la cui giovanissima vita fu sacrificata nel lontano 1945, nei mesi successivi alla liberazione dell’Italia del Nord, nelle campagne del tristemente famoso “triangolo della morte”.
L’avventura di cui diventa protagonista Giorgio Zavagli comincia nel 1968, quando in un fondo del comune di San Possidonio, piccolo centro della Bassa modenese, vengono alla luce i resti mortali di cinque ragazzi appena diciottenni, allievi della scuola militare di Oderzo della Rsi, i cui corsi gli stessi avevano frequentato per otto mesi fino al 25 aprile, impegnati negli studi e nelle esercitazioni d’accademia. Del camion della Pontificia Opera di assistenza con cui a metà maggio 1945 erano partiti da Brescia per ricongiungersi con le loro famiglie al Sud si erano perse le tracce a Concordia, altro comune del “triangolo” dove l’automezzo era stato fermato da reparti della “polizia partigiana” del luogo.
Il ritrovamento era stato reso possibile dalla rivelazione-confessione resa, da un ex partigiano che aveva reso parte all’eccidio, al medico condotto di San Possidonio dottor Pivetti. Questi a sua volta aveva riferito all’amico e collega Zavagli, come l’ex partigiano comunista, appreso di avere pochi mesi di vita per un tumore, gli avesse rivelato i particolari terrificanti di quel massacro, decidendo di inviare ai carabinieri una descrizione anonima dei fatti e indicando in un sommario schizzo topo grafico il luogo dove i corpi erano stati interrati dopo l’esecuzione avvenuta nella notte del 19 maggio 1945. Il medico condotto ripete a Zavagli il racconto di orrori confessato dall’ ex componente della “polizia partigiana”, di come da quei ragazzi, trascinati seminudi e insanguinati sul luogo dell’esecuzione, si levassero strazianti invocazioni alle mamme, urla che per anni avevano risuonato negli incubi di colui che aveva sparato e ucciso in quella notte maledetta. Da quel giorno del 1968, il docente universitario comincia a immedesimarsi nella tragedia delle vittime e delle loro famiglie. Consapevole che «i morti sono tutti uguali e che la storia non deve essere scritta con una penna sola», dedica tutto il suo impegno perché quella tragedia della guerra civile non sia diménticata sotto una cappa di silenzio ma perché il riconoscimento del martirio patito da giovani che non avevano alcuna colpa potesse contribuire alla pacificazione, nel recupero di una memoria storica condivisa come fattore fondante di una ritrovata coesione e unità nazionale.
Zavagli dunque acquista una striscia di terreno nella campagna di San Possidonio proprio dove, in una fossa comune, vennero ritrovati i resti delle vittime. Sempre a sue spese fa fondere una croce di bronzo alta cinque metri, che oggi alle 11, in occasione della festività dedicata ai defunti, viene innalzata e consacrata. Una croce che dominerà le campagne di San Possidonio in segno di espiazione e perdono.
Ma torniamo a 35 anni fa, quando prese l’avvio l’avventura morale di Giorgio Zavagli, intrecciandosi con l’orrore della tragedia. È un pomeriggio del 14 maggio 1945; la guerra è finita da quasi un mese, i tedeschi hanno abbandonato l’Italia, la democrazia ha trionfato. In una piazza di Brescia una piccola folla si accalca intorno ad alcuni camion che inalberano la bandiera pontificia. Sono gli automezzi che la Pontificia Opera di assistenza ha messo a disposizione dei reduci e degli sfollati per consentire loro di tornare a casa e ricongiungersi con le famiglie rimaste oltre la Linea Gotica. I collegamenti ferroviari infatti non sono,
stati ancora riattivati fra il Nord e il resto d’Italia. In quel campionario di umanità che ha attraversato le tempeste della guerra ci sono molti ex internati nei lager nazisti. E ci sono anche cinque diciottenni ancora quasi imberbi: cinque giovani ex allievi della scuola di Oderzo della Guardia Nazionale Repubblicana, muniti di un lasciapassare rilasciato dal Cln di Oderzo, dove i giovani per otto mesi sono stati impegnati in studi ed esercitazioni senza mai partecipare a scontri armati con i partigiani, rastrellamenti o esecuzioni. Ora vogliono soltanto tornare a casa.
Il camion con a bordo i cinque ragazzi parte da Brescia assieme ad altri automezzi diretto a Bologna per la via di Mantova, passa il Po a San Benedetto ma, giunto a Moglia, piccolo centro al confine tra le province di Mantova e Modena, del veicolo si perdono completamente le tracce. Svanito nel nulla Nei giorni seguenti i parenti dei passeggeri scomparsi, molti dei qua1i hanno annunciato per posta l’imminente partenza da Brescia
per far ritorno a casa, si mettono alla ricerca dei loro cari, vagando in un disperato pellegrinaggio fra campi di concentramento alleati, stazioni dei carabinieri, posti di polizia, carceri. Ma alle loro domande risponde un muro di silenzio e di omertà:
Le indagini dei carabinieri – che porteranno poi a un’istruttoria giudiziaria e a un processo in Corte d’assise con imputati alcuni membri della Polizia partigiana della Bassa – accertano che il camion era stato fermato a Moglia da un reparto armato della polizia partigiana che aveva proceduto all’arresto di un primo gruppo di passeggeri. L’automezzo era stato fatto poi proseguire ma, poco dopo, nel vicino comune di Concordia, era stato di nuovo fermato a un posto di blocco della locale polizia partigiana i cui membri erano tutti militanti comunisti. I viaggiatori furono fatti scendere e rinchiusi nelle soffitte di Villa Medici dove già risultavano imprigionate molte persone, uomini e donne, tutte fermate al posto di blocco.
La sentenza della Corte d’assise di Viterbo (che processò e condannò nel 1951 alcuni
componenti della polizia partigiana di Concordia per sequestro di persona e omicidio continuato e aggravato) riporta le testimonianze di persone che riferivano che «di notte si verificavano gli interrogatori dei fermati e si udivano grida e lamenti che a mala pena erano soffocati dal suono di una radio che i partigiani facevano funzionare ad altissimo volume». Gli stessi testimoni rivelavano i nomi dei responsabili dell’uccisione di 16 prigionieri, avvenuta la notte fra il 16 e il 17 maggio, responsabili che venivano condannati ciascuno a 25 anni di reclusione.
Concordia si trova al centro del cosiddetto “triangolo della morte” rimasto tristemente noto per il numero impressionante di eccidi commessi nei mesi successivi alla liberazione di cui rimasero vittime non soltanto fascisti ma anche sacerdoti, professionisti, industria-.
li, donne e privati cittadini, spesso sulla base di un semplice sospetto o perché ritenuti possibili avversari dell’ avvento di un regime comunista in Italia.
Nel 1968 poi, in un campo del vicino comune di San Possidonio venivano ritrovati, interrati in un ex fossato anticarro, i resti di cinque persone. L’autopsia accertò che la morte era stata causata da colpi d’arma da fuoco e da violenti colpi inferti con una vanga. Il ritrovamento era avvenuto sulla scorta della segnalazione giunta ai carabinieri di Carpi nella quale si precisava che nella notte fra il 18 e il 19 maggio 1945 i fermati erano stati trasferiti da Carpi a San Possidonio e lì, in località Dugole Valletta, passati per le armi da appartenenti alla polizia partigiana di alcuni dei quali si segnalava l’identità, peraltro confermata da numerosi testimoni che rivelarono di essersi imbattuti quella notte in un gruppo di persone seminude e legate tre a tre, scortate dai partigiani e provenienti dalla ex casa del fascio.
Nella sentenza istruttoria del giudice Walter Boni del Tribunale di Modena, in cui il capo e tre membri della polizia partigiana di Sari Possidonio erano imputati di omicidio plurimo pluriaggravato, si legge: «Dalle indagini peritali è altresì risultato che i fermati furono percossi a sangue». Faceva parte del gruppo delle cinque giovani vittime innocenti, mio fratello Marcello, classe 1926, matricola dell’università di Roma, facoltà d’Ingegneria. Nel 1952 venne concessa a mia madre la pensione di guerra per il figlio caduto a San Possidonio.”
E c’è ancora, un “incorniciato”, con il titolo “I luoghi del massacro – Una croce sulla fossa comune”, un altro articolo. Eccolo:
“Aveva scritto: «Mamma torno a casa» la lettera, spedita il 14 maggio, arrivò a Roma, dove Marcello Cozzi abitava con la famiglia, il giorno 20 la sera prima, il 19, Marcello era stato fucilato dalla «polizia partigiana». Sul camion (impropriamente chiamato poi corriera) che proveniva da Brescia, con issata la bandiera bianca e gialla del Vaticano, pare viaggiasse un’ottantina di persone. Fra queste sei ragazzi allievi ufficiali della scuola militare della Rsi di Oderzo: Marcello Calvan, Marcello Cozzi, Niccodemo Della Gerva, Franco Gottardi, Cesare Iannoni Sebastiani, Roberto Lombardi, Sergio Piccinini. Non avevano mai preso parte ad azioni di guerra né a rastrellamenti antipartigiani. Tutti furono uccisi e gettati in una fossa comune vicino a San Possidonio, dove oggi viene eretta la croce in loro memoria. Alcuni giorni dopo, il padre di Marcello Cozzi, non vedendo arrivare Il figlio, si recò a Brescia e poi sui luoghi dove il camion avrebbe dovuto transitare. Domandò ai carabinieri e alla polizia, composta da molti ex Partigiani. Non ebbe risposta. La risposta arrivò molti anni dopo, quando sì diede un nome alle ossa (o almeno a gran parte delle ossa) che andavano affiorando dalle campagne del «triangolo della morte». La madre di Marcello, che non si era mai rassegnata all’idea che il figlio fosse stato ucciso, mori prima di poter assistere all’ esumazione dei suoi resti. L’eccidio di San Possidonio non è l’unico del genere. Alcuni giorni prima, il 14 maggio, la stessa sorte era capitata ai passeggeri di un altro camion, anch’esso messo a disposizione dalla Pontificia Opera di Assistenza di Brescia, sul quale viaggiavano circa 25 persone fra civili, militari, ex internati e lavoratori reduci dalla Germania. A Maglia, ancora in provincia di Mantova, i passeggeri furono prelevati dalla «polizia partigiana» del vicino paese di Concordia, rapinati e massacrati. Difficile fu dare un’identità alle vittime, anche le indagini dell’Istituto di medicina legale di Modena su centinaia di frammenti di ossa umane non riuscirono in molti casi a portare alla identificazione”.
P.R.